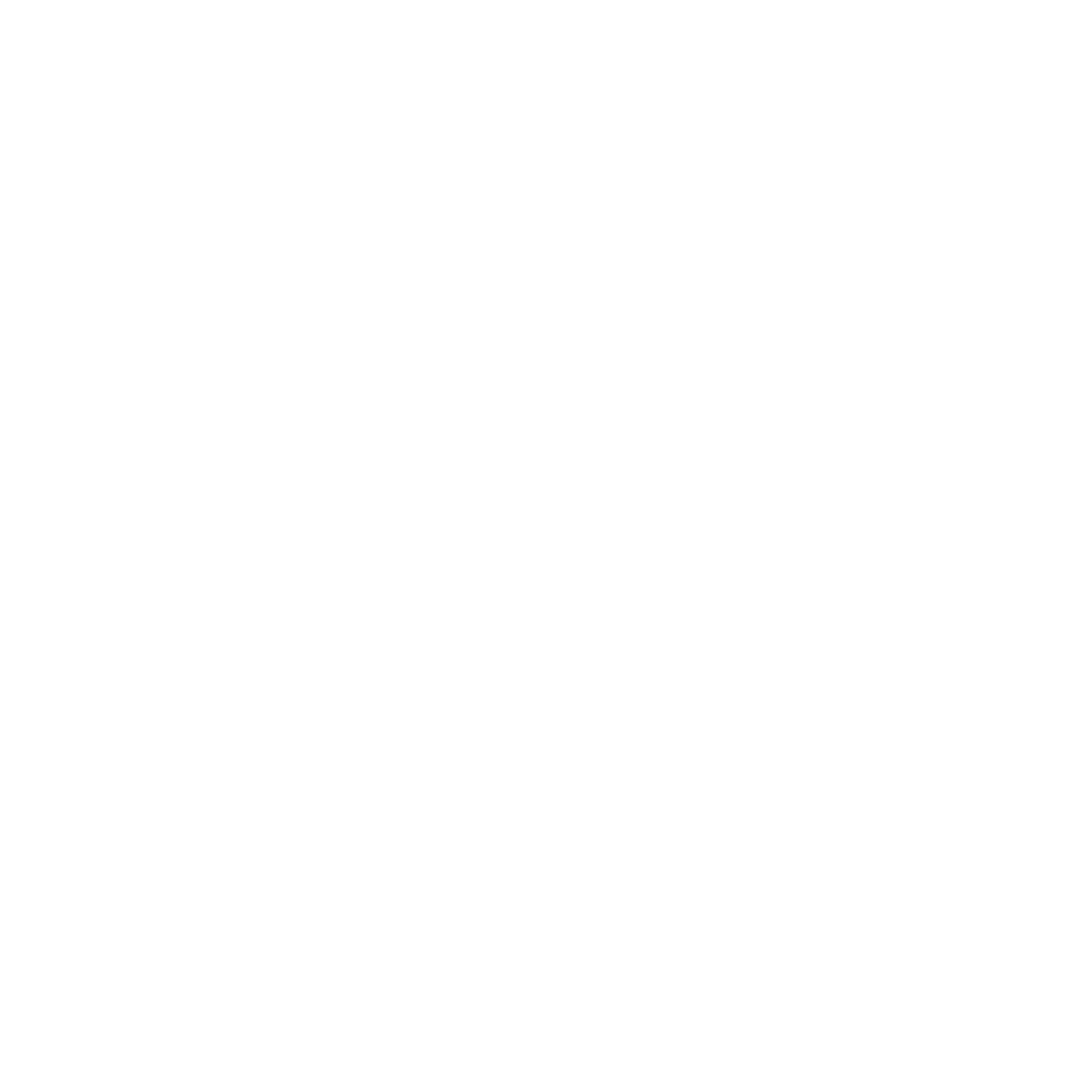Percorrendo via Torino da piazza del Duomo e proseguendo in corso di porta Ticinese, prima di arrivare alle colonne di San Lorenzo si incrocia sulla destra una strada stretta e curva che porta in via Cesare Correnti. È la via intitolata a Gian Giacomo Mora (1587-1630), l’unico barbiere, crediamo, cui spetti questo onore, almeno a Milano. Nella prima casa d’angolo all’incrocio con corso Ticinese, una costruzione della metà Novecento ridipinta di rosa, nascoste in un piccolo portico ci sono una scultura bronzea di Ruggero Menegon, realizzata nel 2005, e una lapide che ricorda lo specifico del luogo. Lì, dove aveva avuto casa il barbitonsore Mora, era stata eretta la «colonna infame», a ricordo perenne del più mostruoso tra i delitti, come ricordava una lapide affissa sulla parete della casa di fronte, che ora è stata collocata nel cortile ducale del Castello Sforzesco, sotto il Portico dell’elefante. «Procui hinc procui», «Lungi da qui lungi, buoni cittadini, ché voi l’infelice infame suolo non contamini», era l’agghiacciante invito che si leggeva in calce all’epigrafe latina.
Ma che cosa aveva fatto il povero Mora? Come racconta Alessandro Manzoni nella Storia della colonna infame, il barbiere assieme al commissario di Sanità Guglielmo Piazza era il principale accusato nel processo agli untori, durante la terribile pestilenza del 1630, processo che si concluse il 1° agosto con la condanna a morte dei rei confessi. Morte avvenuta dopo giorni di atroci torture.
Già verso la fine del 1629 si era registrato a Milano un caso di peste nera: il 22 ottobre Antonio Lovato era rientrato in città da Chiavenna, portando con sé abiti acquistati da soldati tedeschi. Il povero Lovato morì dopo pochi giorni, i suoi famigliari vennero messi in quarantena e tutti mobili e gli abiti di casa bruciati. Nonostante l’allarme, le autorità non vietarono il Carnevale né i festeggiamenti per la nascita dell’infante di Spagna sotto il cui dominio era il ducato di Milano in quel periodo. Gli spostamenti di truppe per la guerra del Monferrato aumentarono le possibilità di contagio. Sicché verso l’estate si era in piena emergenza. Ad allontanare le infezioni e la psicosi non servivano le processioni propiziatorie concesse malvolentieri dal cardinale Federico Borromeo, il quale tuttavia non poteva altrimenti arginare l’isteria collettiva.
In questo clima di paura Alessandro Manzoni fa cominciare il suo saggio storico ultimato nel 1842 che volle pubblicare in appendice a I Promessi Sposi: «La mattina del 21 giugno 1630, verso le quattro e mezza una donnicciola chiamata Caterina Rosa, trovandosi per disgrazia a una finestra d’un cavalcavia che allora c’era sul principio di via della Vetra de’ Cittadini… vide venire un uomo con una cappa nera, e il cappello sugli occhi, e una carta in mano, sopra la quale dice costei nella sua deposizione, metteua su le mani, che pareua che scriuesse». L’uomo con il cappello sugli occhi venne identificato nel commissario di Sanità Guglielmo Piazza. Su di lui pendeva l’accusa più grave: di ungere le porte e i muri del quartiere ticinese per diffondere la peste. Si sospettava che i nemici del Ducato di Milano (e della Spagna) avessero assoldato gente senza scrupoli per favorire il contagio tra la popolazione e, come si dice, indebolire il fronte interno.
Sin dal primo interrogatorio Piazza negò ogni responsabilità: spiegò che camminava rasente i muri perché era una giornata di pioggia. E scriveva perché annotava per il suo ufficio di commissario di Sanità le condizioni igieniche del quartiere e teneva l’elenco delle case abbandonate proprio a causa della peste. Il sospettato mantenne questa versione anche quando gli interrogatori si fecero più pesanti, con l’uso progressivo della tortura, che comportava tra l’altro lo slogamento delle braccia e dei polsi. Dopo tre giorni di sofferenze l’imputato venne lasciato per un po’ in pace, quindi riconvocato dal giudice con la proposta di avere l’impunità se avesse confessato i nomi dei complici. Un delitto così grave non poteva essere compiuto da una sola persona.
Così Guglielmo Piazza, per paura di nuove torture, chiamò in causa il 43enne Giangiacomo Mora, che come tutti i barbieri del suo tempo svolgeva anche funzioni mediche. Aiutato dal giovane figlio – aveva anche tre bambine, l’ultima di soli 6 anni -, in bottega curava ferite, faceva salassi e aveva tra l’altro creato un unguento a base di olio d’oliva, aglio, rosmarino, salvia, ginepro e altre sostanze innocue per lenire i dolori degli ammalati di peste. Le guardie che ispezionarono la bottega e il retrobottega del Mora trovarono anche un grosso recipiente con una sostanza che li insospettì. In realtà si trattava di lisciva per i panni, cioè cenere e acqua. Delle lavandaie interrogate confermarono che in effetti quell’intruglio grigiastro era «smoglio», così il rudimentale detersivo veniva chiamato, ma poiché nel vaso c’erano tracce di sangue e di altri umori, residuo di qualche panno lavato dopo essere stato usato nelle rudimentali pratiche chirurgiche, i sospetti si aggravarono.
A nulla valsero le ripetute dichiarazioni d’innocenza del Mora, poiché i giudici si attaccavano a qualsiasi indizio per arrivare a una sentenza di condanna. A fine giugno, dopo che il barbiere aveva subito le stesse torture del Piazza, avvenne il confronto tra i due. Infine, il 30 anche il Mora capitolò e per sfuggire alle torture confessò la propria colpevolezza. Sì, erano stati lui e il Piazza a ungere muri e portoni per diffondere il morbo… Fu un processo basato sulla violenza e sulla superstizione, denunciate prima che da Manzoni, da Pietro Veri ne Le osservazioni sulla tortura, uscito nel 1777 ma che circolava in bozza già dagli anni Sessanta del Settecento, tanto da influenzare Cesare Beccaria nella stesura di Dei delitti e delle pene (1764).
Il processo si concluse dunque con la condanna a morte di Piazza e Mora, che furono caricati su un carro trainato da buoi e condotti in una macabra processione dall’attuale piazza Beccaria sino a piazza Vetra: davanti a San Bernardino alle monache vennero tormentati con tenaglie arroventate, e in una sosta davanti alla bottega del Mora ai condannati si amputò la mano destra. Giunti al luogo del supplizio, furono legati alla «ruota» e colpiti con bastoni fino alla rottura di tutte le ossa. In agonia rimasero per sei ore esposti alla pubblica vista. Infine furono sgozzati, bruciati e le loro ceneri gettate nel canale della Vetra. La casa di Mora fu rasa al suolo; la moglie, i bambini e i parenti furono allontanati dalla città.
E lì dove sorgeva l’abitazione e il negozio del povero barbiere venne eretta la «colonna infame». Ma l’infamia dei presunti untori si rovesciò dopo molti decenni sulla giustizia milanese, tanto che la colonna fu smontata in una notte e distrutta non a caso nel 1778, un anno dopo l’uscita delle «Osservazioni sulla tortura» di Pietro Verri. Si salvò solo la lapide, che nel 1803 venne trasferita ai musei civici e che, come detto, si può vedere al Castello sforzesco. In via Mora venne davvero commesso un delitto atroce. Il barbiere, però, ne fu la vittima.